di GOFFREDO FERETTO
Qualche mese fa è uscito in Italia, tradotto dal francese, un piccolo libro di sole 120 pagine che ha attirato l’attenzione degli ‘addetti ai lavori’ – teologi, filosofi, storici – ed ha suscitato tanti elogi quante stroncature: ‘La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo’ (Ed. Cantagalli).
Ne è autrice l’autorevole filosofa cattolica Chantal Delsol, docente di filosofia politica e membro della Académie des Sciences morales et politique dell’Instutut de France.
Poiché il titolo del saggio avrebbe potuto trarre in inganno, ho volutamente inserito l’aggettivo cattolica che per sé sarebbe stato inutile e aggiungo anche che la Delsol è da molti ritenuta tradizionalista e lei stessa sembra riconoscerlo (vedi pag. 58).
Che cos’è la Cristianità di cui si parla in questo breve saggio? Ce lo spiega l’autrice: “Si tratta della civiltà ispirata, ordinata, guidata dalla Chiesa. Sotto questo aspetto possiamo dire che la cristianità è durata sedici secoli, dalla battaglia del fiume Frigido, nel 394, fino alla seconda metà del XX secolo, con il successo dei sostenitori dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG)”.
Circa la battaglia citata, si ritiene sia stato l’ultimo tentativo di resistenza alla diffusione del Cristianesimo nell’impero e fu quindi decisiva per il destino della religione cristiana nell’Impero romano e in Europa. Quanto alla data relativa alla IVG, ricordo che in Francia la legalizzazione avvenne con la Legge Veil nel 1975.
L’agonia della civiltà cristiana, secondo la Delsol, è incominciata con l’età cosiddetta dei Lumi e la sua cultura ha lottato due secoli per non morire. Come diceva José Ortega y Gasset, “i secoli moderni sono una crociata contro il cristianesimo”. La caduta della cristianità come civiltà cristiana era inevitabile.
Questa lunga agonia è stata segnata da parte della Chiesa da un fenomeno che sarebbe errato chiamare rinuncia, ma che è stato “una graduale assuefazione a una situazione inizialmente ritenuta inaccettabile …. una lunga catena di compromessi di varia portata”. I due estremi potrebbero essere esemplificati dal ‘Sillabo’ intransigente di Pio IX e dall’enciclica di Giovanni XXIII ‘Pacem in terris’ che aprì la strada al riconoscimento della libertà religiosa, proclamando “esattamente il contrario” di quanto decretato solo un secolo prima.
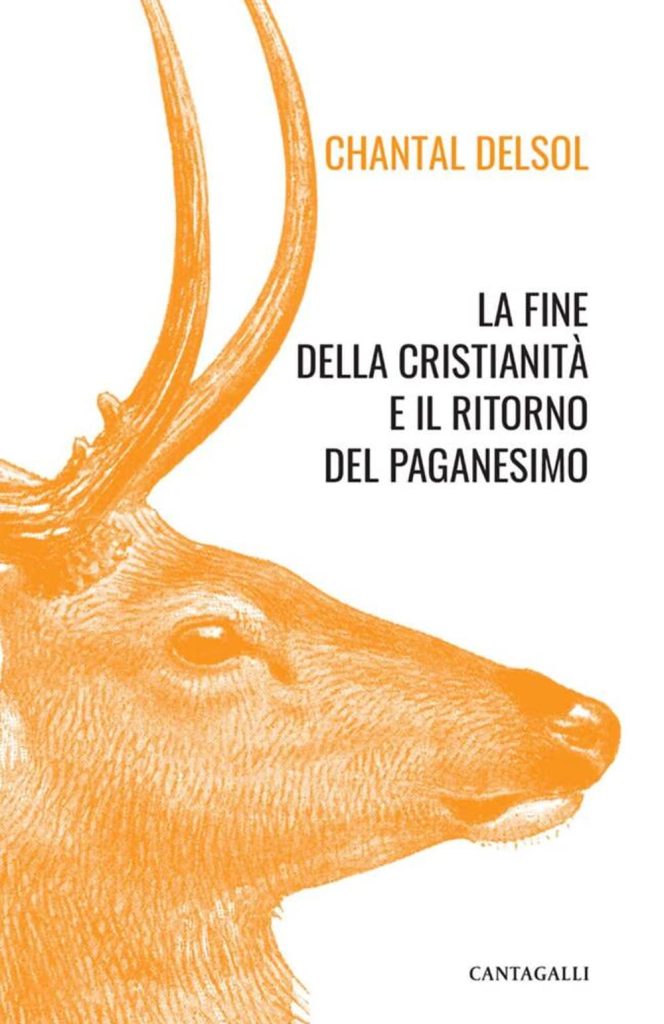
Questa inversione normativa – così la definisce l’autrice – non è stata la sola e non ha riguardato soltanto la dottrina della Chiesa: “A partire dalla seconda metà del XX secolo e, in modo particolarmente significativo dagli anni ’60, le nostre gerarchie morali si sono letteralmente capovolte… nel mondo dei nostri padri, la colonizzazione era generosa e ammirevole, la tortura e la guerra erano solo l’ultima risorsa; oggi la colonizzazione e la tortura sono gesti satanici, come lo è, in larga parte, anche la guerra”. Pleonastico approfondire altri esempi di cambiamento-capovolgimento della morale sociale rispetto al divorzio, all’omosessualità, al suicidio assistito.
Insomma, questi ultimi due secoli sono “la storia di una sconfitta dove tutto è stato aspramente conteso, ma dove nulla è stato salvato… una lotta all’ultimo sangue persa in anticipo”.
Fin qui l’analisi lucida, spietata, quasi cinica e dai toni categorici in relazione al primo tema trattato.
Vediamo il secondo, il ritorno del paganesimo.
“I cristiani hanno creduto a lungo – scrive la Delsol – e molti di loro lo credono ancora, che potrebbero essere sostituiti solo dall’ateismo, dal nichilismo o da entrambi allo stesso tempo. In altre parole, da forme negative che seminerebbero tenebre e tempeste”. La realtà, però, è un’altra: “Smettiamo di credere che siamo gli unici al mondo che possono dare un senso al mondo. Il regno cristiano è già sostituito, né dal nulla, né dalla tempesta, ma da forme storiche ben note, più primitive e più rozze. Dietro il crollo della cristianità non c’è il regno del crimine, il nichilismo, il materialismo estremo, ma piuttosto morali stoiche, il paganesimo, spiritualità di tipo asiatico”.
Una di queste forme è quello che l’autrice definisce “il panteismo asiatico” di matrice buddista, visto che “le offerte religiose asiatiche corrispondono alle aspirazioni contemporanee. Non sono legate alla nozione di verità, da qui il loro sincretismo che appare falsamente agli occidentali come tolleranza. Attribuiscono un valore essenziale alla natura e a tutti gli esseri viventi, il che è una condizione per l’adesione all’imprescindibile e irrinunciabile ecologia. Non brandiscono alcun dio, alcun dogma, alcun obbligo”.
Ecco nominata l’ecologia che occupa un intero capitolo del libro, non a caso intitolato ‘L’ecologia come religione comune’.
“In questo inizio del XXI secolo – scrive la Delsol – la corrente filosofica più affermata e attraente è una forma di cosmoteismo legato alla difesa della natura. Si può anche parlare di panteismo o politeismo. I nostri contemporanei occidentali non credono più in un aldilà o in una trascendenza… il sacro si trova qui: nei paesaggi, nella vita della terra e negli stessi umani”. Secondo un autore citato nel testo – Philippe Descola – si tratta di una antropologia monista che si avvicina all’antico animismo. Eccoci arrivati al neopaganesimo.
“L’ecologia oggi – continua l’autrice – è una religione, una credenza. ‘Credenza’: non è che l’attuale problema ecologico non debba essere considerato scientificamente dimostrato; ma perché queste certezze scientifiche sul clima e sull’ecologia producono convinzioni e certezze irrazionali, in realtà credenze religiose, dotate di tutte le manifestazioni della religione”. È assolutamente evidente che “abbiamo tutta una tradizione cristiana di difesa della natura, da san Francesco o santa Ildegarda di Bingen fino a Gustave Thibon, ai nostri giorni. In questo caso, la natura è considerata come una creazione divina e come tale protetta – la difesa della natura si inserisce all’interno della fede nella trascendenza e di un umanesimo che pone l’uomo al centro. Si parla allora di ambiente, e la natura non può essere divinizzata, poiché il divino è altrove. Quando la cristianità svanisce, e con essa la trascendenza, è inevitabile che il sacro riappaia in una forma o nell’altra”.
La madre terra, insomma, è diventata una specie di dea pagana “e non solo tra gli indigeni boliviani, ma anche tra gli Europei”.
La nuova morale, il cui sommo sacerdote non è più un capo religioso, ma lo stato stesso, le sue élite culturali, “riprende quella vecchia e la adatta, o addirittura la camuffa o la manipola”, insomma ci troveremmo di fronte a una forma di parassitismo: “Quando lo Stato moderno nasce svincolandosi dalla religione, può farlo solo appoggiandosi sull’eredità religiosa”.
In pratica “si tratta di utilizzare effettivamente tutti i materiali possibili ma di privarli dei loro significati per reiventarli a beneficio della nuova era”. E di questo fenomeno l’esempio più clamoroso, addirittura lampante, è costituito dal riutilizzo delle parole: “Le parole cariche di significato vengono riprese e deviate. L’epoca contemporanea avrebbe potuto, per esempio, proporre un nuovo vocabolo per designare l’unione di due persone dello stesso sesso, ma usa volutamente il termine ‘matrimonio’ per rinnegarne il significato. Il suicidio assistito potrebbe essere legittimato… e affidato alla responsabilità di un personale con una denominazione specifica: il fatto di voler affidare questo compito a dei medici falsifica il significato stesso di medicina (lo stesso vale per l’IVG)”. Tale snaturamento di antichi vocaboli è volutamente mirato a trasformare il senso del mondo. L’idea stessa di verità, secondo l’autrice, sta scomparendo e il cristianesimo che se ne riteneva in qualche modo detentore “appare ormai come una narrazione, anche se una bella narrazione affascinante”. Che cosa è rimasto? Afferma la filosofa: “Si assiste allo sviluppo di una filantropia, di un amore per l’umanità direttamente ereditato da quello del Vangelo, ma senza averne i fondamenti: anche in questo caso siamo in pieno parassitismo… La tarda modernità riprende il Vangelo e persino nel senso letterale, ma spogliandolo di ogni trascendenza”.
L’ultimo capitolo del saggio reca il titolo di ‘Cristianesimo senza cristianità’ e si apre con una domanda: “Che diventerà la Chiesa senza la cristianità?”
La reazione di fronte allo sconvolgimento radicale appena descritto sarebbe “in particolare tra i chierici quella della rassegnazione e della rinuncia”. L’inversione normativa di cui si è parlato “ha colpito duramente l’istituzione (Chiesa n.d.r)” che oggi arriva a guardare al proprio passato spesso con vergogna e si sente in dovere di chiedere scusa, di recitare il mea culpa, il che era assolutamente impensabile ai tempi del ‘Sillabo’.
I cristiani sono ormai minoritari e “ quando si è minoritari, la tolleranza non è più una virtù, ma una necessità legata alla propria condizione; le virtù sono l’equanimità, la pazienza e la perseveranza… questa situazione senza precedenti nella nostra storia ci riporta finalmente all’età dei primi cristiani”.
L’epoca dei primi cristiani è stata l’epoca della testimonianza senza condizioni: pochi, ma fedeli e determinati.
“Si può pensare il cristianesimo sul modello dei monaci di Tibherine”, scrive la Delsol. Chi erano costoro? Erano 9 mitissimi religiosi che vivevano di preghiera e testimonianza in Algeria, 7 dei quali furono assassinati nel 1996 da un gruppo di criminali, tra i quali anche alcuni che avevano direttamente beneficato. Non facevano propaganda, ma affermavano la loro fede con la loro vita, vivendo con i contadini del posto e condividendone l’estrema povertà. Con l’amore e il fino al martirio.
Tutti martiri perciò i cristiani di oggi? Ovviamente no, ma testimoni credibili e perseveranti sì.
Un resto di Israele, per dirla con la Bibbia, vivo e vivace, che proclama la propria fede e tiene acceso il fuoco della Parola divina.
Il libro si conclude con questa frase: “Rinunciare alla cristianità non è un sacrificio doloroso. L’esperienza dei nostri padri ci offre una certezza: il nostro compito non è produrre società dove il Vangelo governa gli stati, ma per usare le parole di Saint-Exupéry, di ‘camminare adagio adagio verso una fontana’”.
È più che logico che questo saggio abbia suscitato non solo elogi, ma anche critiche furibonde.
