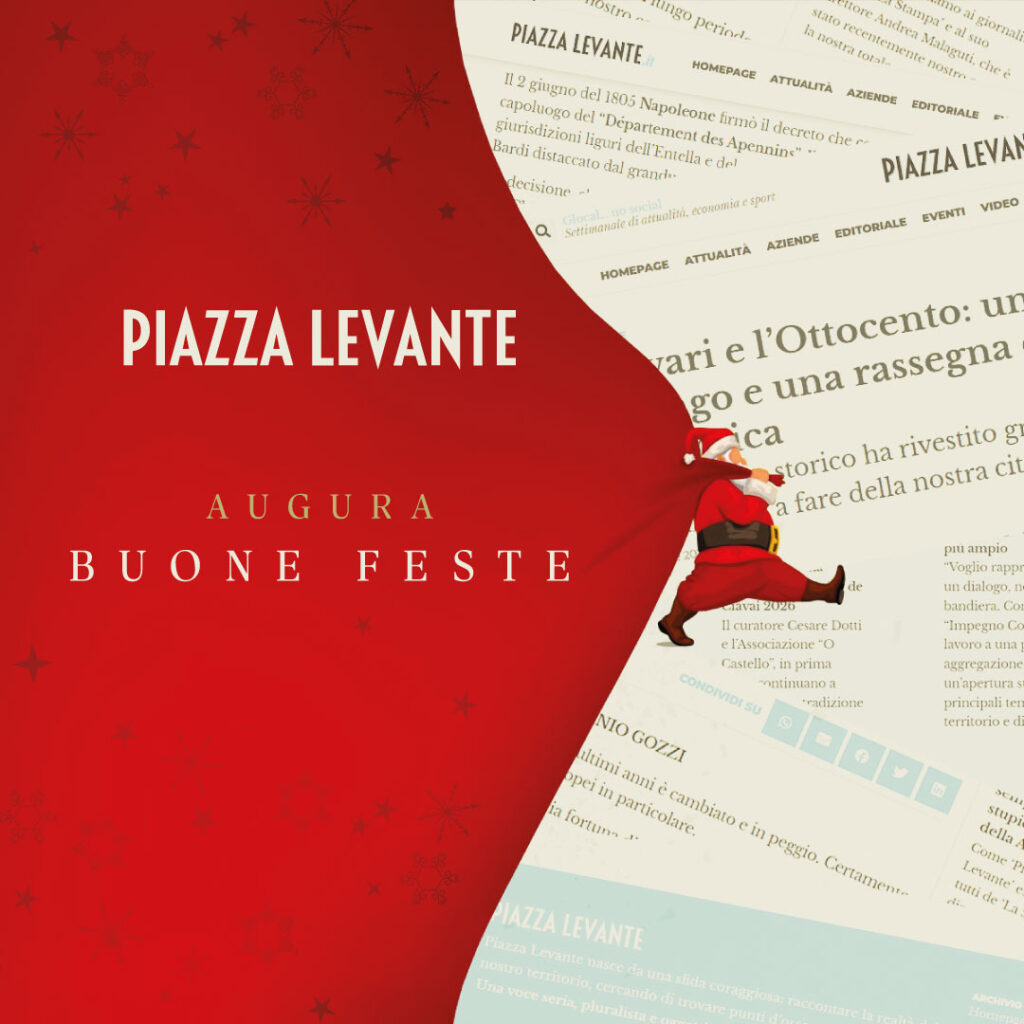di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *
Sabato 6 aprile l’associazione ‘Il Bandolo’ ci ha regalato una preziosa occasione di riflessione e conoscenza grazie alla professoressa Francesca Neonato del Politecnico di Milano. La conferenza era incentrata sul valore della natura nelle nostre città, uno studio tra biodiversità, storia urbanistica e nuove proposte per un futuro urbano ambientalmente sostenibile.
La Neonato ha illustrato in quattro punti salienti come le nostre città possono essere resilienti in una strategia e progettazione eco ambientale.
Il primo aspetto sottolinea come il verde cittadino-urbano richieda una visione d’insieme del costruito e delle aree verdi, cioè una capacità di dialogo progettuale tra i diversi elementi: gli alberi, le fasce boschive, le siepi, i prati e altro. Il secondo punto richiama la necessità di una conoscenza puntuale del verde, ricercata secondo parametri multifunzionali e di produzione di servizi ecosistemici. Gli ultimi due punti, molto legati tra di loro, richiamano precisi regolamenti comunali del verde per formulare carte individuabili come ‘Piani del Verde Urbano’. Quest’ultima voce dà una presenza progettuale individuabile e leggibile nei bilanci comunali e nelle strategie progettuali previste nel tempo.
Ho immediatamente pensato di riportare nel nostro piano urbano, nella storiografia di Chiavari, questa moderna chiave di lettura, come un modello per valorizzare una possibile Città Verde Natura.
La prima questione era l’individuazione di un punto di partenza, un periodo storico nel quale il verde urbano diventa elemento progettuale. Questa data è individuabile nel progetto del 1826, quando si realizza il ‘Piano Generale d’Abbellimento della città di Chiavari’: ben 52 articoli per dare un nuovo volto alla vecchia e superata visione della città fortificata, il primo nucleo fondativo della Chiavari medievale. È bene chiarire subito che nulla fu distrutto del nucleo del XII secolo, ma si tracciarono linee guida per la futura crescita urbanistica, e per consolidare questo concetto si stabilì che il portico rimanesse come elemento caratterizzante le nuove progettualità edilizie. Veniamo al verde e agli spazi giardino introdotti negli articoli del grande progetto: prima di tutto si dispose che tutte le nuove viabilità fossero intese a viali e corsi, cioè con misure delle carreggiate tali da garantire la piantumazione di alberi, così la rettifica delle piazze e degli slarghi di raccordo.

Per le nuove progettazioni delle piazze desidero richiamare ad esempio l’articolo 28 relativo a piazza Nostra Signora dell’Orto. “La piazza di N.S. dell’Orto che serve di passeggiata sarà regolarmente piantata e suddivisa. Gli alberi da preferirsi sarebbero quelli a foglia verniciata che meglio può resistere agli aridi marini cioè l’elce, il pino, il corbezzolo, l’alloro, il bozzo e l’arancio detto volgarmente selvatico”. In poche righe si può leggere una vera rivoluzione progettuale, con l’uso di parole mai inserite prima, il concetto di piazza che serve per passeggiare e gli alberi per garantirne un notevole livello di qualità.
Qui un dato, un interessante confronto: la nuova espansione avrebbe utilizzato ampi spazi ad uso ortivo, ma come era caratterizzata la città del tempo, come erano utilizzati orti e colline? Il lavoro statistico di Lazzaro Boeri può aiutarci a reperire dati utili: i contadini e ortolani a Chiavari erano 1410, il territorio era caratterizzato da 455 ettari d’oliveti, 35 ettari d’orti, 357 ettari di seminativi, 155 di boschi castagneti, 180 ettari di boschi e pascoli naturali. Questi dati impressionanti, non più leggibili ai nostri giorni, risalgono al 1872, ben cinquant’anni dopo il progetto sopra richiamato, e con una intera superficie comunale di 1200 ettari.
Il Piano d’Abbellimento andava oltre e indicava altre soluzioni progettuali; l’articolo 46 ribadiva che “tutte le passeggiate dovranno essere piantate ad alberi”. Il successivo prescriveva che “la strada che da Rupinaro conduce al mare sarà portata a dieci metri di larghezza e sarà piantata ad alberi”. A quest’ultimo punto vorrei rammentare che il corso Millo aveva un ampio fascione a ‘rissêu’(ciottolato) spietatamente asfaltato circa quindici anni or sono, cancellando la totale permeabilità del paraggio. Sempre l’articolo 47 deliberava che la “strada che corre tra Rupinaro e raggiunge il Paraxo (la strada che conduceva alle Grazie) sarà piantata d’alberi”.
A questa sensibilità deve essere aggiunto il Piano Regolatore dell’Ingegner Timossi che prevedeva la nuova città tra l’attuale corso Garibaldi e vicolo dei Grimaldi (attuale corso Millo). Anche in questo caso a completamento dei nuovi insediamenti vengono sempre prescritti la piantumazione del verde e l’utilizzo dei giardini.
Per concludere vorrei ricordare le progettualità di primo Novecento: l’asse viale delle Palme – corso Buenos Aires e la Circonvallazione a Monte, due opere volute da subito con una forte caratterizzazione del verde urbano. La prima di queste viene intitolata non a figure storiche, ma alle Palme. Come dimenticare la sostituzione di queste con le magnolie e il conseguente rovinoso taglio di queste ultime ormai monumentali? Questi avvenimenti produssero, è bene non dimenticarlo, la presenza elettorale cittadina di una ‘Lista Magnolia’.
Ancora vogliamo ricordare la Circonvallazione, con un concorso d’idee voluto dalla Società Economica. Era un progetto che concerneva un nuovo attraversamento dell’intera collina; vi si prevedeva un particolare marciapiede di transito con tasselli-aiuola dove posizionare alberi di leccio.
Vorrei concludere con un ricordo della Famiglia Rocca, il benemerito donatore del più ampio parco cittadino. Le commoventi foto del grande fotografo Alfred Noack ritraggono il costruendo parco collinare disegnato dall’architetto Polline Caccia. Giuseppe Rocca regalò il palazzo e il parco alla nostra città, un vero unicum, un cuore verde nel centro urbano.
La professoressa Francesca Neonato ci ha raccontato come il verde delle città sia determinante per la nostra ricchezza più grande: la qualità della vita. Forse è bene fare tesoro dei suoi preziosi consigli.
(* storico e studioso di tradizioni locali)