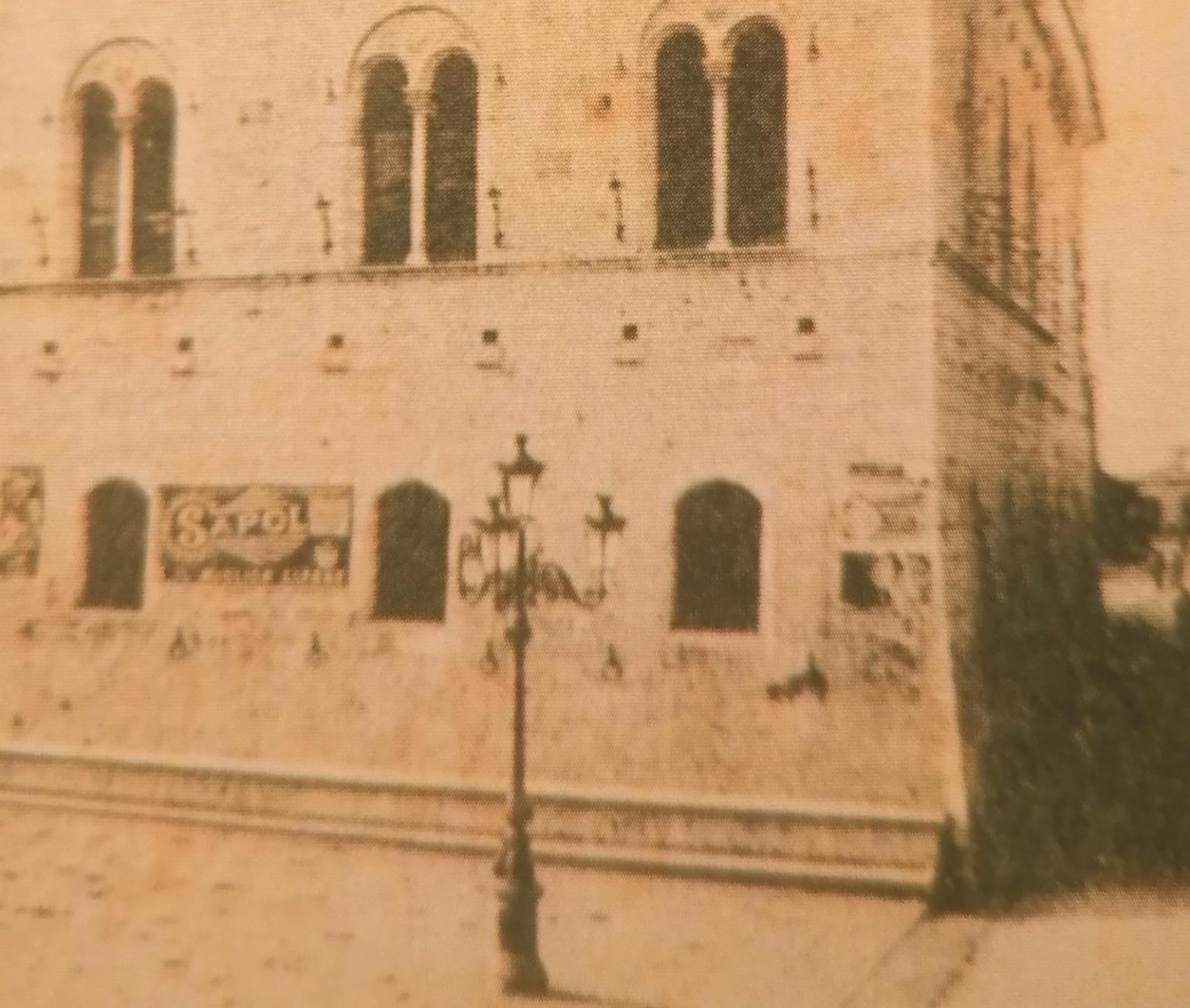Prosegue la serie di articoli di Giorgio ‘Getto’ Viarengo dedicati ad illustrare la Chiavari dell’Ottocento e i tanti modi ed aspetti per i quali questo può a buon diritto essere riconosciuto come ‘il secolo d’oro’ della nostra città.
di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *
Il cammino dell’illuminazione pubblica segna lo sviluppo delle nostre città nel corso della storia. Avere le strade dei centri cittadini percorribili anche di notte fu uno dei maggiori e diffusi desideri in ogni comunità: le grandi capitali europee ne facevano vanto, e Parigi fu celebre per essere “la Ville Lumière”. Proprio questa definizione fu efficace metafora del grande progetto culturale francese, e la diffusa illuminazione notturna divenne rappresentazione e simbolo del successo dell’illuminismo come filosofia capace di scacciare il buio dell’ignoranza.
Per secoli si tentò in diversi modi di rompere il buio notturno, ma la vera diffusione dell’illuminazione stradale trovò sviluppo nel XIX secolo, quando si iniziarono ad installare lampioni, lanterne e lumi per migliorare la percorribilità notturna nelle città che si aprivano a questa innovazione.
In Chiavari un primo esperimento d’illuminazione cittadina ebbe luogo, grazie all’iniziativa privata della Società Economica, la sera del 3 aprile 1796, quando quattordici lanterne a olio furono posizionate in Carrugio Dritto. Immediata fu la partecipazione generosa del marchese Stefano Rivarola, che donò altre quaranta lanterne subito distribuite nel borgo di Rupinaro.
Con tale iniziativa Chiavari aveva precorso le altre città liguri: la stessa Genova fu dal Governo provvisorio dotata di una prima sperimentale illuminazione notturna solo sul finire del 1797. Le cronache di quegli anni ci raccontano di diverse occasioni caratterizzate dall’accensione di luci artificiali, in particolare durante festeggiamenti e commemorazioni importanti. Come non rammentare le istruzioni dettate da Monsignor Agostino Rivarola al suo fattore chiavarese Michele Daneri: “M’ingiunge d’ordinarvi che, oltre I’illuminazione ordinaria che si fa mettendo quattro o cinque cartoni in tutte le finestre della casa che danno sulla strada Rivarola e sui giardini dalla parte della Madonna dell’Orto, facciate eseguire sull’arco esterno che corrisponde al portone della casa un’illuminazione a disegno che abbia l’aria di una piccola facciata illuminata”.
Dal tono della missiva si comprende il valore dell’uso della luce notturna e il suo significato pubblico: “Queste sono idee sulle quali i chiavaresi devono essere fecondissimi, essendo i lumetti di loro particolare e festevole istituzione… Vi avverto che i lumi devono essere piuttosto fitti e a brevi distanze tra un lampadino e I’altro, senza di che parrebbero “unna rela de fidé in un’amua de broddu” (una matassina di vermicelli in una coppa di brodo).
Perché il progetto dell’illuminazione pubblica diventi un obiettivo dell’istituzione comunale è necessario attendere il 1807, cioè di nuovo l’amministrazione francese; in tale data si avviò il servizio partendo dalle piazze del centro urbano chiavarese. Per finanziare tale progetto si stabilì un’imposta straordinaria sulle pigioni, da devolversi al finanziamento della pubblica illuminazione notturna. La prima previsione di bilancio verificabile la si può trovare nel documento contabile del 1806 da attuarsi l’anno successivo: nella contabilità del municipio di Chiavari sono previste spese per lire 9.033, di cui una quota superiore al 10% per “illuminazione notturna della città” con un importo previsto di lire 1.000.
Ricercando presso la documentazione dell’Archivio Storico del Comune di Chiavari possiamo verificare alcune carte che ci informano della gestione del nuovo servizio. Nel giugno del 1818 si procedeva ad una verifica dell’illuminazione, e dal verbale risultavano accese ed in esercizio 72 lampioni ad olio; sempre dal rilievo e secondo il regolamento le luci furono realmente accese per 13 sere. Dalla lettura del dispositivo risulta infatti che l’accensione era permessa quando la luce della luna non era troppo chiara. In caso contrario non si procedeva all’avvio perché la luce del lampione sarebbe risultata troppo flebile rispetto a quella irradiata dalla luna, e quindi inutile ai fini dell’illuminazione della via.

L’olio per l’accensione era fornito dal venditore Franco Bianchi con magazzino di deposito alle Saline; il prezzo del combustibile per due mesi aveva un importo di lire 123,33. Erano inoltre necessari al servizio gli addetti all’accensione, che costavano lire 2,50 ad accesso.
La documentazione ci permette di verificare anche alcuni costi di manutenzione e dei ricambi necessari per garantire il miglior funzionamento e la regolare fiamma nel lampione. A quel controllo le lastre di vetro sostituite risultavano 6 per un costo di lire 1,25 cadauna; il cerino rosso installato sulla canna d’accensione costava 7,30 lire per due mesi d’esercizio.
Sempre dai documenti conservati si può rilevare che erano previsti dei “controlli per accertarsi se vi era l’olio necessario nei suddetti contenitori” per l’accensione. Il controllo era a campione e prevedeva la stesura di un verbale con l’esito della verifica effettuata. Il 22 giugno del 1864 si testarono tre punti luce: “Nel fanale situato nella Chiesa di San Giacomo, nel fanale situato nella casa del signor Lagomaggiore, nel fanale situato nella casa della Chiesa di San Giacomo di Rupinaro”. Il verbalizzante affermava “che in tutti e tre c’era l’olio necessario e furono da me fatti discendere abbasso e verificati alle ore 5”.
Le verifiche erano effettuate perché il servizio era ritenuto di notevole importanza e le polemiche sulla gestione dell’appaltatore non erano lievi. Si giunse ad un atto con la pubblicazione di un’inchiesta per gli anni 1846, 47 e 48. Il gestore Giacomo Lertora, impresario dell’illuminazione, era indagato per le pretese avanzate e articolate in un documento che suscitò una lunga polemica in città.
La situazione dell’illuminazione cittadina si espanse e sviluppò considerevolmente con l’arrivo del gas: tutti i lampioni furono adeguati al nuovo combustibile, e persino l’accensione era di molto semplificata, così come la resa dell’effetto illuminante.
La luce di notte spalancava le porte al futuro.
(* storico e studioso delle tradizioni locali)