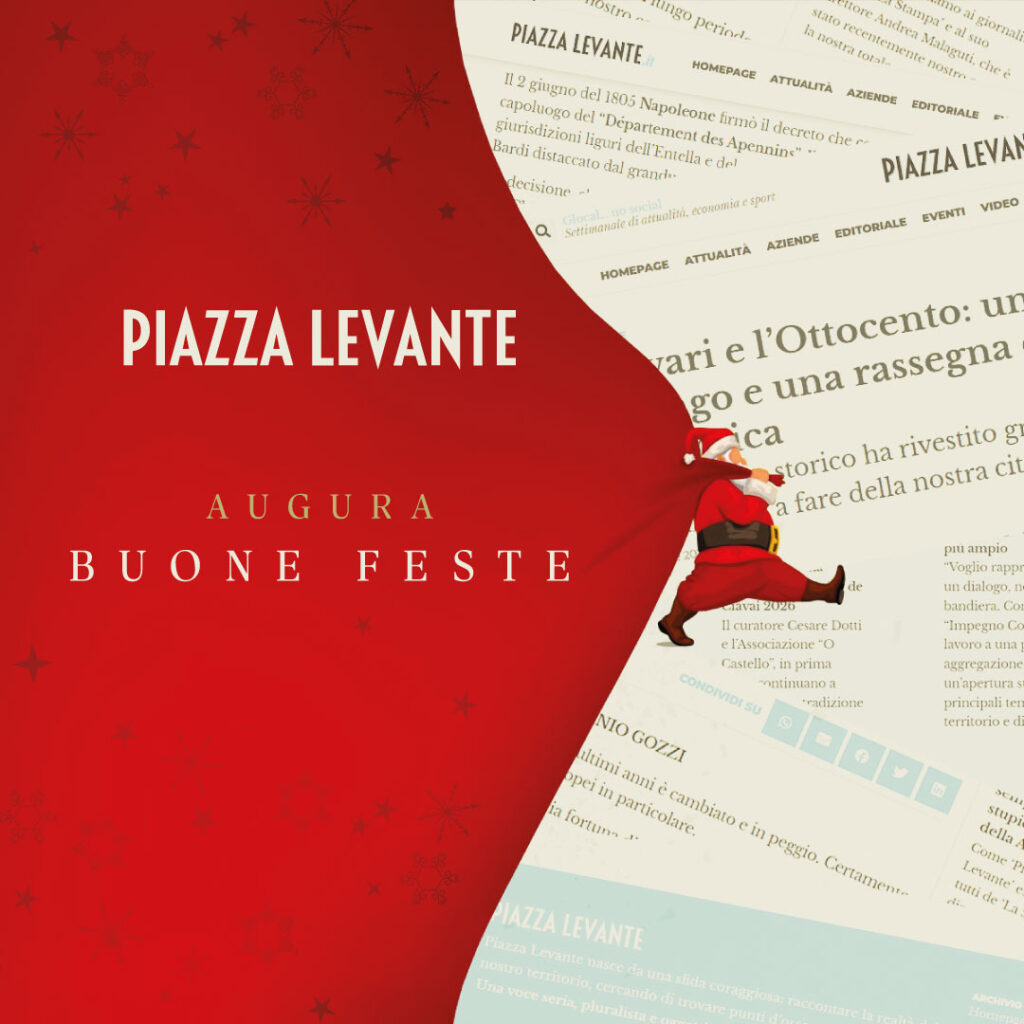di GIORGIO ‘GETTO’ VIARENGO *
Se vi soffermate a leggere l’epigrafe affissa al vecchio palazzo del dazio, all’angolo tra via Piacenza e corso Lavagna, troverete un’importante indicazione che così può essere riassunta: qui passa la strada che unisce il mare all’Appennino.
Erano gli anni del governo del Regno di Sardegna con Re Carlo Alberto e quella viabilità affermava un principio importante: la necessità di porre fine a uno storico isolamento tra costa ed entroterra. Lo stesso governo attivava un progetto che riguardava l’intero territorio del regno in fatto di viabilità, la ‘legge sulle strade obbligatorie’: il provvedimento invitava i comuni a progettarle attivando specifici ‘consorzi’.
Nell’Archivio Storico di Chiavari sono conservate le carte che documentano la progettazione e la realizzazione della ‘Chiavari – Lagomarsino’, opera approvata dal governo di Torino il 22 aprile del 1848.
Nelle diverse relazioni troviamo un riferimento importante: “Nell’allargamento dell’antica mulattiera fino a conservare tali e quali i due ponti posti a Carasco sul Lavagna e sullo Sturla”. Questa frase ci indica che la realizzazione avrebbe ricalcato il percorso più antico, la mulattiera, allargandolo e rettificandolo per trasformarlo in carreggiabile.
L’attraversamento dei corsi d’acqua non prevedeva un nuovo ponte, ma l’utilizzo delle strutture già presenti. Se adeguiamo la lettura di tutte le viabilità che attraversano il territorio a questa indicazione, non faticheremo ad individuare le ‘porzioni’ più antiche – le mulattiere – nell’evoluzione dell’uso del territorio.
Ho provato ad applicare questa ‘lente di lettura’ e le scoperte sono davvero molte. Già nell’immediata periferia chiavarese, in via Parma, è leggibile un portale monumentale che assicurava l’accesso ai tipici casali rurali. La struttura è ben più antica dell’attuale strada e ne indica il rinnovato utilizzo come carrettabile. Proseguendo, raggiungendo San Lazzaro, possiamo soffermarci dalla cappella e verificare la vecchia viabilità che sale verso l’antico toponimo di San Giorgio di Comorga: questo tratto conserva il vecchio impianto col selciato a ‘rissêu’, il passo della gradinata è quello tipico e unificato delle mulattiere.
Questa rilettura potrebbe proseguire per l’intero sviluppo delle viabilità, restituendo tratti di notevole interesse. È il caso di Mezzanego, dove possiamo ricercare la vecchia viabilità entrando verso Valcarnella, attraversando il vecchio ponte per raggiungere l’oratorio di San Rocco (nella foto in alto) e riguadagnare la moderna viabilità attraversando il vecchio centro storico della frazione Prati. Più avanti, all’imbocco della strada verso il Passo del Bocco, in località Borgonuovo, ecco la vecchia viabilità del ponte di via Botto: uno scorcio storico importante e tuttora interamente leggibile.
Le ‘vecchie viabilità’ erano stratificate nel tempo e raggiungevano in modo razionale tutte le comunità, erano formate da una serie fittissima di strade ‘comunali’ e ‘vicinali’, raggiungevano le curve di livello più alte per ramificarsi nuovamente.
Quest’ultima ricerca è quella capace di evidenziare i ‘sentieri’, microviabilità che permettevano di attraversare interi territori collinari, sino a cablarsi con viabilità più ampie, capaci di raggiungere località extraterritoriali oltre Appennino. Appare singolare il voler ricercare la fittissima rete che tutt’oggi sale dal Centro Storico di Chiavari per attraversare l’intero arco collinare di San Ruffino – Leivi. La sua conservazione è proprio dovuta all’articolazione ‘istituzionale’ che specifica il titolo e l’inquadramento delle viabilità ‘comunali’ e dalle ‘vicinali’: qui entra in campo la storia del diritto agrario, degli antichi catasti, dei termini per conservare i confini delle diverse proprietà e comuni.
Sino agli anni Quaranta, annualmente si rivedevano le intere reti comunali dei sentieri, gli uffici comunali aggiornavano lo stato delle viabilità e, proprio nelle diverse responsabilità di manutenzione tra ‘comunali’ e ‘vicinali’, stanziavano i fondi per le manutenzioni.
L’intero territorio viveva d’economia agraria, la campagna era una risorsa e le viabilità garantivano gli scambi e i commerci. La cartina dei sentieri di Chiavari restituisce un territorio completamente servito dai sentieri, sin dall’immediato Centro Storico a salire verso le colline di Leivi (all’epoca San Ruffino).
La prima frattura avverrà nel 1900: in tale data l’ingegner Riccardo Questa progettava la Circonvallazione a Monte, una nuova viabilità che permetteva l’attraversamento a nord della città. Con la nuova viabilità maturava l’esigenza di attraversare la collina di Leivi, i progetti prevedevano due diverse soluzioni: una viabilità dal piazzale dei Cacciatori, l’altra da Sampierdicanne.
Nel tempo saranno realizzate entrambe, anche in questo caso ricalcando le viabilità più antiche, i sentieri e le mulattiere che da secoli collegavano il territorio.
Dall’esame della cartografia troviamo riferimenti di notevole interesse: strada della Mula, il Ronchetto, la Chiusa; tutti toponimi di attività specialistiche storicamente legate ad attività agrarie. Tornando al punto di partenza del piazzale dei Cacciatori, possiamo fare una ricerca su questa indicazione: la caccia.
Tutta la costa che sale dal Centro Storico di ‘Capo Borgo’ è caratterizzata da ‘roccoli’ per l’attività venatoria: dalla zona di via Mafalda di Savoia a salire verso Case Malpertuso, si possono tuttora intercettare le vecchie ‘oxele-e’ (uccelliere), casette per la caccia di posta. Se si percorre l’intera costa collinare, sino a raggiungere la torre di San Ruffino, se ne contano una dozzina.
La rete dei sentieri continua nei territori vicinali, travalica e scende in Fontanabuona: il Comune di San Colombano conserva una cartografia che illustra la fitta rete dei collegamenti sino alle vette più alte verso il Ramaceto.
Raggiungere le dorsali più interne significa intercettare i collegamenti con la viabilità dell’Alta Via dei Monti Liguri, una viabilità unitaria che si avvia dal ponte di Ceparana, siamo nell’estremo levante spezzino, sino a raggiungere La Colla a Ventimiglia. Circa 440 chilometri di sentieri e mulattiere, vie di transumanza e percorsi di montagna, colli e passi, attraversando l’intero arco appenninico ligure.
Non sarebbe difficile trasformare l’impianto dei nostri sentieri in una rinnovata proposta turistica, dove l’escursionismo può trovare importanti proposte e attività da praticare. La rete dei B&B, degli agriturismi delle nostre colline potrebbe rinnovarsi in una specifica accoglienza, in una nicchia di ospiti che cerca nuove occasioni nell’escursionismo.
Quest’estate è stato restituito il sentiero delle Rocche di Sant’Anna, un progetto sostenuto dal Comune di Sestri, una proposta per verificare come recupero ambientale e turismo sono in forte accordo e possono percorre le medesime strade. In più occasioni si era predisposta una viabilità che raggiungesse, partendo da Chiavari, Portofino, un arco escursionistico che cablasse le storiche Cinque Torri per ampliarsi verso Rapallo – Caravaggio – Ruta – Portofino.
Ancora una proposta, indicava la realizzazione di una bretella di sentieri capace di raggiungere dalla costa l’Alta Via e proseguire sia verso ovest che verso est. Queste riflessioni, e i precedenti articoli sul ‘verde’ promossi da ‘Piazza Levante’, vogliono davvero trasformarsi in proposte-risorse per l’intero territorio. I diversi articoli, sino ad oggi pubblicati, rappresentano ricerche che indicano una possibile progettualità, dove le nuove economie possono svilupparsi nell’articolazione tra ambiente-agricoltura-cultura-turismo: una solida catena capace di costruire futuro.
(* studioso di storia e di tradizioni locali)